La cultura e la ricerca umanistica dellʹEuropa. Una politica delle
risorse tra consapevolezza, concorrenza e sviluppo
di Valentina UghettoIl 29‐30 ottobre 2008, si è tenuto a Roma, presso la sede di Porta Castello, il
convegno ʺLa cultura e la ricerca umanistica dellʹEuropa, una politica delle
risorse tra consapevolezza, concorrenza e sviluppoʺ, promosso, sotto lʹalto
patronato della Presidenza della Repubblica, dallʹUniversità LUMSA, insieme
allʹAssociazione degli Istituti Italiani di Cultura, alla Fondazione Enérgeia e
allʹUnione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dellʹArte
in Roma.
I lavori sono stati aperti dal prorettore Giuseppe Ignesti, docente di Storia
delle Relazioni internazionali, il quale ha proposto di approfondire il rapporto
tra cultura e gestione politica delle risorse economiche. In particolare, il
prorettore ha sottolineato la necessità di instaurare un più stretto rapporto tra
istituzioni e società civile, per mantenere l’attività delle istituzioni stesse più
aderente agli sviluppi culturali attuali. Attività di mediazione che, per
mancanza di fondi, sta venendo a mancare.
Sempre in fase di apertura dei lavori, il direttore della Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea, Pier Virgilio Dastoli, si è soffermato sulla
tema della cultura come bene e come investimento sul futuro da parte delle
istituzioni europee. A seguire, l’intervento di Andrea Purgatorio ‐ portavoce del
sindaco di Roma, Gianni Alemanno ‐ il quale ha dichiarato di essere
assolutamente consapevole dellʹimportanza e del valore della cultura anche per
la classe politica e amministrativa. Una cultura – ha precisato in seguito
Purgatorio ‐ che non deve però essere unipolare, bensì di carattere liberale, cioè
in sintonia con la “tradizione continentale vincente”. Nel concludere, oltre a
consigliare la lettura di Francis Fukuyama, La fine della storia e lʹultimo uomo, il
portavoce di Alemanno ha altresì voluto sottolineare che un modello
propriamente detto di società non si è ancora definitivamente affermato e che
lʹepoca delle contrapposizioni sarà in realtà piuttosto lungi dal concludersi.
A chiudere i saluti inaugurali, la lettera di Silvia Costa, assessore
allʹIstruzione, diritto allo studio e formazione della Regione Lazio, che ha messo
l’accento sull’importanza del sostegno statale sia alla cultura umanistica che a
quella scientifica attraverso borse di studio e lavoro per i neolaureati.
Dopo i saluti delle autorità, è iniziata la sessione “La cultura come politica:
lʹinsegnamento dellʹesperienza storica”. Il dott. F. Marin, del Consolato dʹItalia a
Stoccarda, ha introdotto nel dibattito un’esposizione del modello universitario
tedesco nellʹEuropa dellʹOttocento. Tale modello, ispirato alla lezione
humboldtiana, risultava basato su cinque pilastri, che possono essere riassunti
come segue: la concorrenza tra le varie università, il federalismo, la libertà
d’insegnamento e di apprendimento, lʹimperativo della ricerca, il ruolo di
indirizzo dello Stato. La Bildung, o formazione dello studente, era intesa come
sintesi di unità di sapere, anche se, ad avviso del dott. Marin, gli ideali di von
Humbold si sono affermati soprattutto nelle scienze naturali e umanistiche
anglosassoni nordamericane.
Jean‐François Chauvard, dell’Ecole française di Roma, è intervenuto
descrivendo lʹattività scientifica, lʹistruzione e la politica dellʹEcole durante il
periodo 1873‐1946. In un primo periodo, lʹattività dell’istituto era quasi
totalmente concentrata sugli studi di archeologia, cosa che ha consentito di
intensificare e di rafforzare progressivamente i rapporti tra l’Ecole, altri istituti
di cultura e le famiglie romane più influenti, il cui assenso risultava decisivo per
l’apertura degli scavi. Tuttavia, dato il perdurare delle restrizioni ai permessi
per gli scavi, l’attenzione dell’Ecole si spostò progressivamente dall’archeologia
allo studio paleografico e diplomatico delle lettere pontificie.
Il Direttore dellʹIstituto per la storia del Risorgimento italiano, Giuseppe
Talamo, ha illustrato le origini del suo Istituto e lʹautonomia culturale di questo,
pur nel variare delle vicende politiche. Il suo intervento si è concluso con un
riconoscimento a favore della legge Ronchey, che ha permesso di finanziare i
restauri del complesso del Vittoriano e lʹapertura del museo risorgimentale al
pubblico grazie a fondi privati.
Il prof. Andrea Ciampani, della facoltà di Giurisprudenza della LUMSA,
ha posto lʹaccento sulle diverse realtà presenti al congresso, ossia sul mondo
interessato alla ricerca, formato per una parte dagli archivisti, dai docenti, dai
ricercatori e, per lʹaltra, dai politici. Il suo ruolo di promotore dellʹevento,
insieme alla presidenza della Facoltà e ad altri colleghi, lo ha visto
ripetutamente intervenire nel corso dei lavori per assicurarne un soddisfacente
svolgimento.
Conclusa la prima sessione, riguardante la prospettiva storica tra ricerca
scientifica e politica culturale, si è aperto un dibattito sulla possibilità odierna di
reperire e consultare materiale archivistico. La prof.ssa Paola Carucci,
consulente archivistica del Quirinale, ha espresso molte perplessità per il futuro
degli archivi, poco considerati economicamente e prossimi allʹimpossibilità di
operare. Ha trovato però parole di speranza suggerendo come soluzione ai
problemi contingenti lʹaccorpamento del materiale di consultazione degli
archivi storici comunali e regionali in unʹunica sede per ciascuna regione,
mantenendo però l’unità e la specificità storica e archivistica dei fondi.
La dott.ssa K. Rahn, del Deutsches Historisches Institut, ha illustrato i
problemi che si sono creati nel riordinare tutto il materiale documentario che la
Germania ha recuperato con il crollo del muro di Berlino, a causa della difficoltà
di ottenere risorse sufficienti per un progetto a breve scadenza. La soluzione,
per limitare le spese, è stata quella di informatizzare tutta la documentazione e
creare una “finestra dellʹamministrazione”. Gli archivi, per la dottoressa Rahn,
dovrebbero essere raffigurati con lʹeffigie di Giano bifronte che guarda allo
stesso modo al passato e al futuro.
Dopo aver definito gli interventi possibili e gli ostacoli economici al
sovvenzionamento della cultura, si è arrivati alla sessione del convegno
intitolata “Al di là degli eventi: la cultura della politica e la politica della
cultura”.
La senatrice Vittoria Franco, della VII Commissione Permanente,
Istituzione Pubblica Beni culturali, ha accusato lʹanti‐politica, che ha portato il
nostro paese allʹabbandono dell’interesse per le politiche culturali. Ha inoltre
affermato lʹimportanza della responsabilità pubblica per una cultura che crei
legami d’identità e affermi la tolleranza, al fine di poter crescere
individualmente e socialmente.
Ha preso poi la parola Andrea Graziosi, presidente della Società Italiana
per la storia contemporanea, che ha insistito sulla difficoltà di reperire i fondi
per la ricerca in un momento di declino economico, auspicando al tempo stesso
scelte più consapevoli nei confronti dei progetti da finanziare. Il presidente
dell’AICI (Associazione istituzioni culturali italiane), Gerardo Bianco, ha riferito
sui tagli effettuati negli ultimi anni al bilancio del Ministero dei Beni Culturali.
Il Rettore dellʹUniversità LUMSA di Roma, Giuseppe Dalla Torre Del
Tempio di Sanguinetto, ha aperto la seduta mattutina della seconda giornata
parlando con ottimismo della politica culturale europea e dei diversi paesi
dellʹUnione, che offrirà ai cittadini senso di appartenenza e valorizzazione della
ricerca umanistica.
La professoressa della LUMSA Lia Fava Guzzetta ha ribadito che lʹEuropa
ha la consapevolezza di una sua identità politica, economica e culturale, ma ha
posto allʹattenzione di tutti come tale identità vada conservata e accresciuta con
un impegno costante di studi e di investigazione scientifica del patrimonio
artistico, letterario, storico e umanistico. La condizione necessaria e sufficiente
al permanere di tale identità è il sostegno economico dell’Europa, in maniera
continuativa e certa, nei confronti dei progetti di studio e ricerca degli
storici, degli Archivi, delle Accademie, degli Istituti di ricerca universitaria e
delle Associazioni nazionali, visto il ruolo fondamentale svolto da tali
istituzioni nel promuovere e nell’incrementare la crescita della vita sociale e
culturale europea.
Stando alla riflessione del dottor Walter Geerts, direttore dellʹAccademia
del Belgio, nella concezione politica dellʹUE la cultura deve approfondire
soprattutto le scienze sociali, demografiche e statistiche. Tuttavia Geerts ha
ribadito che se viene a mancare lo studio e la ricerca per tutte le altre discipline
lʹimpoverimento degli studi renderà di nuovo attuale la vexata quaestio tra
scienza pura e applicata, che si risolve nella domanda alquanto provocatoria:
“quando non cʹè scienza cosa cʹè da applicare?”. Lʹintervento si è concluso con
un riferimento allʹUnione internazionale degli istituti di archeologia, storia e
storia dellʹarte in Roma, che è una rete dʹeccellenza composta da 34 istituti.
Geerts ha affermato l’importanza della sopravvivenza di tale rete per garantire
lo sviluppo della ricerca umanistica all’interno dell’UE.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda comunque al sito
<www.unioneinternazionale.it>.
Per il Gruppo di collegamento degli storici dellʹEuropa contemporanea
presso la Commissione europea ha parlato il professor Andrea Varsori,
dell’Università di Padova, il quale ha accennato alle ultime vicende del Gruppo
di collegamento, importante centro di promozione di una visione europea
dellʹintegrazione culturale, ad oggi in grado di sostenersi grazie alla liberalità
del governo del Lussemburgo.
Per le interdipendenze tra politiche della cultura e della ricerca nelle
scienze umanistiche, F. Criado, del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas di Madrid, che ha tenuto un discorso assai analitico in spagnolo, ha
rimandato per ulteriori approfondimenti sulla differenza di interpretazioni e
metodi al sito spagnolo del Consejo Superior.
Il dibattito riguardante le culture nazionali tra europeizzazione e sfida
globale ha contrassegnato la mattina della seconda giornata di lavori. Il
direttore del Goethe Institut di Roma, prof. Uwe Reissig, ha descritto le
modalità di finanziamento dei progetti del Goethe, lamentando la decisione di
sospendere il finanziamento dei corsi di lingua allʹestero, i quali restano
comunque in attivo per merito delle capacità gestionali e della competenza dei
docenti. Il professore Jean Dominique Durand, docente dellʹIstituto di Storia del
cristianesimo dellʹUniversità Jean Moulin 3 di Lione, ha preso la parola
individuando nell’immigrazione una sorta di detonatore per l’attuale
rivoluzione culturale e religiosa europea. Si assiste a una ripresa del dubbio, in
una società laica come quella europea, sulla vita e il posto dellʹuomo. In Francia
è tornato forte il senso di spiritualità religiosa nella discussione politica, benché
non ancora da tutti riconosciuto, se non in alcune località, come Lione, il cui
sindaco ha nominato un consigliere per gli affari religiosi. Duran ha ricordato
lʹintervento di Benedetto XVI al convegno di Parigi del 12 settembre 2008, in cui
rievocava le esperienze monastiche di S. Paolo e S. Benedetto e la loro difficoltà,
allora come oggi, di far comprendere i valori religiosi perché nella moltitudine
d’interpretazioni delle sacre scritture “Dio è tornato il grande sconosciuto”. Le
scritture sacre, secondo Duran, devono essere interpretate dal clero, perché, in
caso contrario, sarebbe più elevato il rischio di fondamentalismo.
A conclusione di una lunga mattinata, in cui è intervenuto anche il
senatore Mario Baccini, Vincenzo Cappelletti ha descritto le attività da lui
dirette della Société Européenne de Culture di Venezia e con il suo ottimismo
contagioso ha regalato a tutti i presenti un raggio di sole: “Nessun pessimismo
può offuscare la nostra fiducia nella vita”.
Con i tempi di chiusura della mattinata ormai incombenti, il dottor
Bernard Stolte, del Reale Istituto Olandese a Roma, ha espresso un giudizio
positivo sulle tecniche scientifiche come strumento funzionale anche alle
ricerche umanistiche, preconizzando un Rinascimento virtuale, con musei
interattivi e lʹinformatica utilizzata nelle sue infinite applicazioni.
Nel pomeriggio della seconda giornata, Lutz Klinkhammer, del Deutsches
Historisches Institut, ha rilanciato le suggestioni di Stolte , auspicando una
sempre più intensa cooperazione tra le scienze e lʹarea umanistica. Il professor
Emiel Lamberts, dellʹUniversità cattolica di Lovanio (Leuven), intervenendo su
“Le culture delle famiglie politiche europee nella mondializzazione”, ha tenuto
un discorso articolato e complesso a proposito delle correnti politiche del XX e
XXI secolo, prendendo a modello la teoria dei colori di Goethe per meglio
descriverne la variegata complessità.
Sempre in tema di cultura e politica, il prof. Lorenzo Medici,
dellʹUniversità degli Studi di Perugia, ha trattato il tema dellʹUNESCO, mentre
il dott. Jean‐Marie Palayret, direttore degli Archivi delle Comunità Europee di
Firenze, ha sottolineato lʹimportanza dei progetti di una cultura alta in Europa,
ricordando tra lʹaltro la nascita degli studi di perfezionamento post laurea in
fisica nucleare avvenuti con il programma Euratom.
M. Mèhuet, per lʹAEDE di Parigi, ha fatto proprio il motto: “la nazionalità
si acquisisce alla nascita, la cittadinanza si apprende”. Con il suo francese
gentile ha messo lʹaccento sullʹimportanza delle nostre tradizioni, ma anche
sulla conoscenza degli altri per poter divenire pienamente cittadini europei e
migliorare la convivenza civile. Nella sessione dedicata ai metodi da seguire per
la formazione europea dei ricercatori nel campo delle scienze umanistiche, sono
state prese in esame le linee guida del cosiddetto processo di Bologna,
notoriamente inaugurato nel giugno del 1999. Il prof. Paul Richard Corner,La cultura e la ricerca umanistica dell'Europa. di Valentina Ughetto
docente dellʹUniversità di Siena, ha discusso della difficoltà di far riconoscere
gli esami sostenuti allʹestero, nellʹambito del programma Erasmus per
lʹuniversità, con il rischio di costringere lo studente a ripetere lʹesame al rientro
nel suo paese. Di fatto, ha sottolineato il prof. Corner, si tratta di una perdita di
tempo e denaro per tutti. Unʹesperienza positiva si è tuttavia verificata con un
consorzio di sette Università europee, che ha dato luogo al titolo di studio
universitario Euromaster. Italia (Siena), Gran Bretagna, Francia, Spagna,
Germania e altre nazioni offrono la possibilità di sostenere gli esami in più sedi,
mentre la laurea conseguita con lʹEuromaster è un titolo riconosciuto in
ciascuno di questi paesi. Oltre agli impedimenti burocratici, il professore
Corner vede ancora come grosso limite la mancata conoscenza da parte dello
studente di due lingue europee oltre a quella madre.
Sempre per la valorizzazione della cultura umanistica, il professore
Simone Neri Serneri di Siena ha chiesto un maggior impegno da parte dei
politici nel destinare risorse per la ricerca. Per far sì che vi sia una giusta
valutazione del problema da parte del governo Neri Serneri ha auspicato che
tutto quello che avviene negli istituti culturali possa essere reso pubblico come
in un bando. A tal fine ha previsto che, per una maggiore limpidezza, vengano
pubblicati i curricula, le attività delle istituzioni culturali per l’affidamento degli
incarichi e tutte le pubblicazioni. Anche una giovane ricercatrice dellʹUniversità
di Cracovia ha posto lʹattenzione sulla trasparenza dei bandi e la
diversificazione delle carriere per uno sviluppo e una concorrenza efficaci.
Il senatore Roberto Di Giovan Paolo, consapevole del ruolo della cultura
in un paese civile, ha ribadito la necessità di garantire, in questo periodo di
crisi, non solo la sanità e le pensioni, ma anche la cultura, come bene fondante
della società. Gherardo La Francesca, direttore generale per la Promozione
culturale del ministero degli Affari Esteri, comprendendo anch’egli la necessità
di investire nella cultura del paese e riprendendo il tema della crisi economica
sollevato dal senatore Di Giovan Paolo, ha indicato come soluzione un
maggiore impegno per razionalizzare le risorse e incrementare le energie
rinnovabili.
Nella proposta del documento conclusivo del convegno si accenna ad una
rinnovata azione politica a sostegno della ricerca scientifica in campo
umanistico, da portare avanti non solo a livello europeo, ma anche a livello
nazionale. È stato tra lʹaltro ricordato che, nonostante sia stato più volte
presentato, il disegno di legge finalizzato al sostegno della ricerca scientifica in
campo umanistico non è mai stato discusso dal Parlamento europeo. In
definitiva, il convegno, lungi dal contrapporre la cultura scientifica a quella
umanistica, ha voluto ribadire che la salvaguardare e promuovere la cultura
umanistica significa tutelare le stesse fondamenta del “convivere” civile.
http://www.eurostudium.uniroma1.it/rivista/recensioni/numero%2010/La_cultura_e_la_ricerca_umanistica_dell'_Europa_Valentina_Ughetto.pdf
di Valentina Ughetto
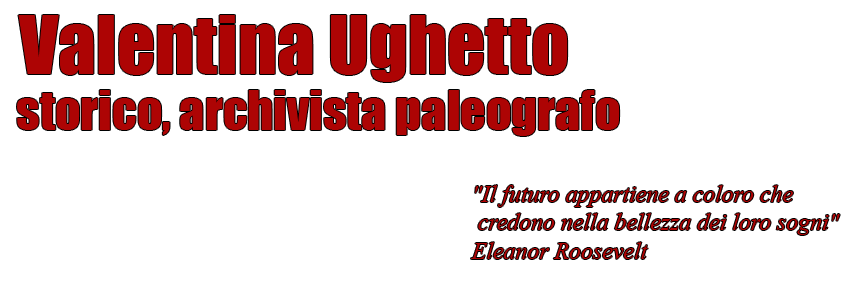
Nessun commento:
Posta un commento